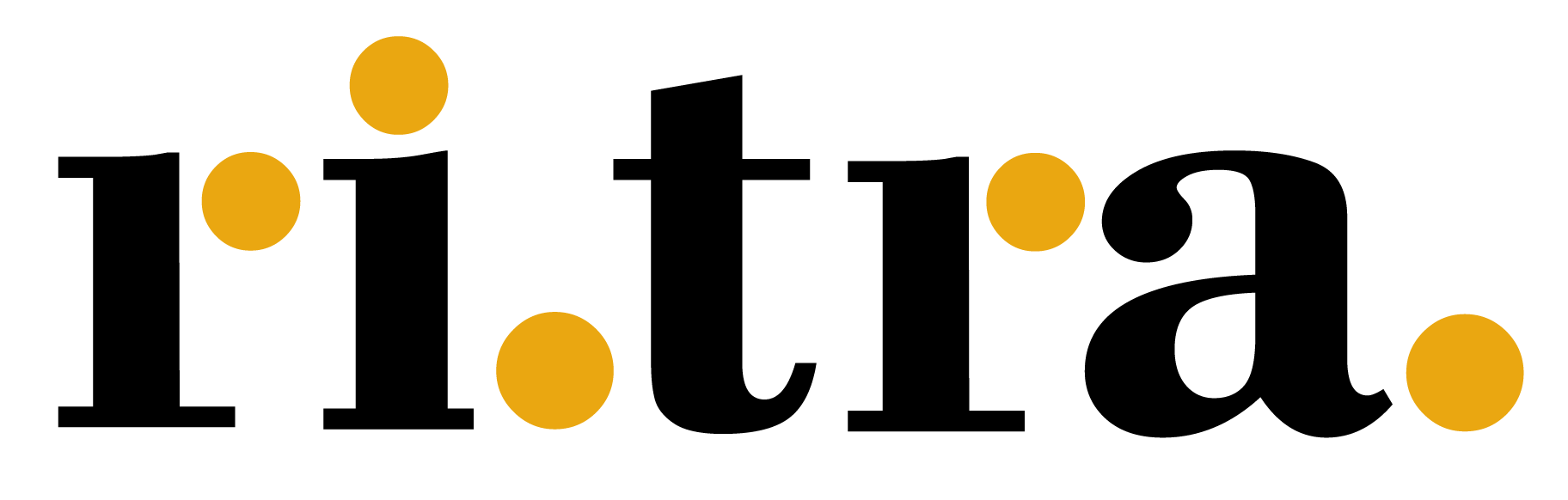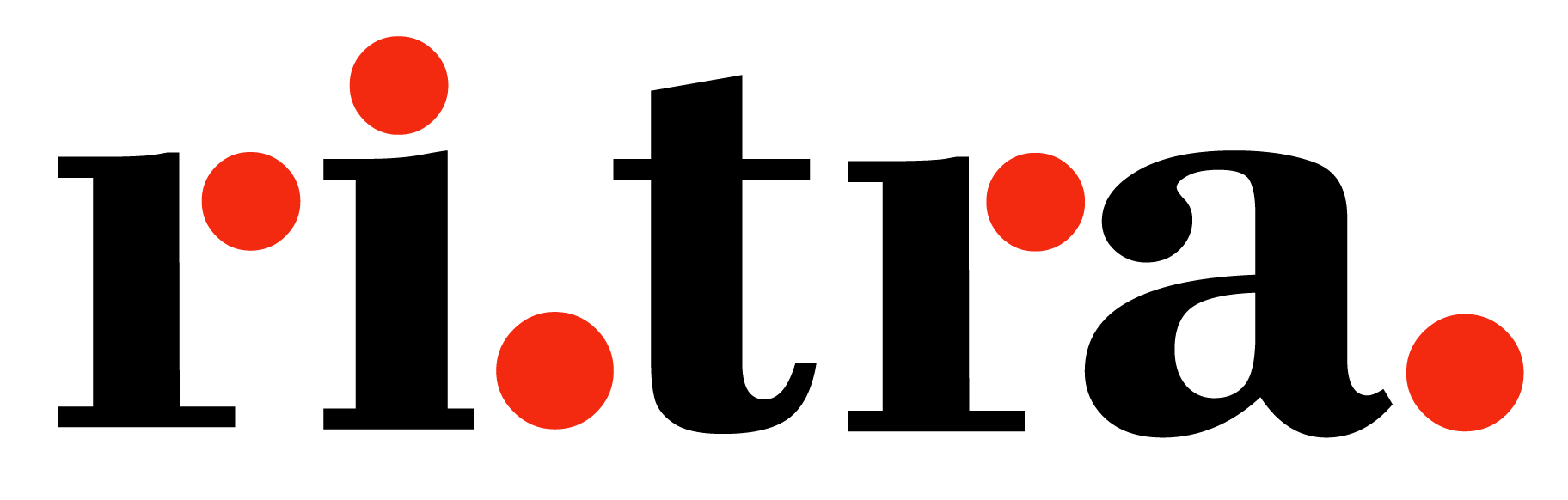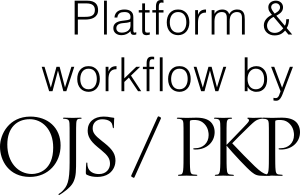Vai al blog di ri.tra
Sulla rivista
«ri.tra» è un rivista scientifica (peer-reviewed) internazionale, che esce a cadenza annuale sulla piattaforma OJS SIRIO dell'Università degli Studi di Torino. Si occupa di teoria, pratica e storia della traduzione, in una declinazione plurale e con un focus principale sulla traduzione verso l'Italia.
«ri.tra» è affiancata da una collana e da un blog: i quaderni di ri.tra raccolgono studi monografici, atti di convegno e materiali di diverso genere non riducibili al formato della rivista; il blog ritra.it presenta in anteprima i contenuti della rivista e propone inoltre altre rubriche, segnalazioni, spigolature e contenuti audio e video.
Com'è nata «ri.tra»
Le riviste dedicate alla traduzione pubblicate in Italia, o con focus sull’Italia, per fortuna non mancano. Accanto alla più antica, «Testo a fronte» (fondata nel 1989), ci sono almeno la «Rivista internazionale di tecnica della traduzione» (1992), «inTRAlinea» (1998), il «Journal of Italian Translation» (2006) e «translation: a transdisciplinary journal» (2011), senza contare quelle che, come «Ticontre: teoria testo traduzione» (2014), riservano alla traduzione un interesse specifico sebbene non esclusivo. Perché, allora, una nuova rivista?
Alla fine del 2021 si è conclusa l’esperienza di «tradurre. pratiche teorie strumenti», fondata da Gianfranco Petrillo. In dieci anni e 21 numeri «tradurre» si era conquistata un posto importante in questo panorama, arricchendolo non poco, e chiudendo ha lasciato un vuoto e un’eredità. Alcuni dei suoi redattori hanno pensato che fosse importante raccoglierla, lanciandosi in una nuova impresa. A questo primo nucleo si sono aggregati altri studiosi di traduzione, provenienti da ambienti ed esperienze diversi ma congruenti, come il progetto LTit – Letteratura tradotta in Italia, il CeST – Centro Studi sulla Traduzione di Siena, lo History and Translation Network, la scuola fenomenologica di Emilio Mattioli, ma anche singoli ricercatori, giovani e meno giovani. Dopo lunghe chiacchierate, dense di proposte e programmi, ci si è accordati su un titolo, il più trasparente possibile: «rivista di traduzione», abbreviato «ri.tra».
«ri.tra» è dunque un progetto nuovo, ma dell’esperienza di «tradurre» raccoglie alcune istanze ormai consolidate: un’idea di traduzione non normativa ma descrittiva, un approccio dunque più fenomenologico che ontologico; un’attenzione spiccata per traduttrici e traduttori, in particolare per le loro biografie e le loro poetiche; l’indagine sulla storia della traduzione, o meglio delle traduzioni, in Italia; il proposito di mettere in dialogo, sul tema della traduzione, le discipline più diverse, dalla storia alla filosofia, dalla linguistica alla critica letteraria, dagli studi culturali alla storia del teatro, dalle neuroscienze alle nuove tecnologie; e soprattutto la persuasione che studiare le traduzioni sia un modo per indagare anche altro: la storia, la cultura, la società. Anche per questo il sottotitolo di «ri.tra» allude a quello di «tradurre» e alcune rubriche (Studi e ricerche, Traiettorie) portano lo stesso nome. Come «tradurre», infine, «ri.tra» è redatta in italiano, con l’intento di contribuire a diffondere e consolidare la consapevolezza di una ‘tradizione della traduzione’, non solo nella sua dimensione transnazionale ma anche e soprattutto nella sua peculiare declinazione italiana.
«ri.tra» è un rivista scientifica, nel senso che i suoi redattori appartengono per lo più al mondo accademico e che viene redatta secondo gli standard della comunità scientifica internazionale, a partire dalla peer review. Ma come «tradurre» intende rivolgersi anche a un pubblico più vasto: traduttori, editor, insegnanti e lettori genericamente interessati alle questioni della traduzione.
«ri.tra» esce una volta all’anno ed è pubblicata in open journal system (OJS) sulla piattaforma SIRIO dell’Università degli Studi di Torino. Pur essendo una rivista digitale, è redatta in modo da poterla leggere su carta come un libro: il pdf integrale di ciascun fascicolo, se stampato in A5, ha dimensioni e la leggibilità simili a quelle, familiari ai più, di un volume della collana 'Saggi' dell’Einaudi.
Il logo di «ri.tra» è di Mauro Sullam.
Per informazioni, proposte e suggerimenti l’indirizzo a cui scrivere è info@ritra.it.
Le rubriche
«ri.tra» è articolata in rubriche, ciascuna curata da due redattori. Oltre allo spazio aperto che è Studi e ricerche, ne sono state per ora inaugurate sei. Eccone una breve presentazione.
Il tema
a cura della redazione di «ri.tra»
Il tema individua un argomento specifico intorno al quale far convogliare una serie di saggi: non studi singoli, come in Studi e ricerche, ma dialoganti su un tema comune. La cura della rubrica è affidata, di numero in numero, a un redattore della rivista e/o a uno studioso ospite. Tra gli argomenti che «ri.tra» si propone di esplorare ci sono – in ordine rigorosamente sparso – la storia della traduzione in Italia, la traduzione teatrale, il rapporto fra traduzione e intelligenza artificiale, la postura dei traduttori, le traduzioni da singole letterature straniere, specie le meno frequentate le traduzioni indirette, le traduzioni di saggistica, di canzoni pop, di fumetti, di film d’animazione, le antologie di traduzioni, le collane di traduzioni, il ruolo delle agenzie letterarie e del diritto d’autore nella traduzione, la teoria della traduzione, la tradizione della traduzione in Italia…
Extraduzione. I testi italiani tradotti in altre lingue
a cura di Giulia Baselica e Frédéric Ieva
Le teorie, le pratiche e le storie della traduzione attraversano confini spaziali e temporali in una duplice direzione. Se da un lato tracciano la mappa dell’acquisizione, da parte della nostra lingua e della nostra cultura, di testi appartenenti a tradizioni altre e destinati a modificare comunque – in maniera impercettibile o profonda – il contesto di accoglienza, dall’altro offrono il riflesso che i testi prodotti dalla nostra tradizione proiettano, in altra lingua, sulla cultura straniera che li incorpora. La rubrica Extraduzione propone storie di narrazioni – letterarie, saggistiche, teatrali – che, nella contemporaneità o in altre epoche, con una nuova fisionomia linguistica hanno messo radici al di là dei confini nazionali, diventando, così, elementi integranti di una diversa cultura. Assimilati a modelli già esistenti o acquisiti come paradigmi innovatori, i testi tradotti in altra lingua si offrono a inedite e, non di rado, inattese letture, rivelando significati rimasti inespressi nella cultura che li ha originati. Ex-traduzione è dunque la pratica traduttiva di testi ex-patriati, magari ispiratori di riflessioni e contributi alle teorie della traduzione, sempre descrittive e mai prescrittive.
Traiettorie
a cura di Anna Baldini e Davide Dalmas
Traiettorie presenta studi sulle persone che hanno contribuito al processo di mediazione delle letterature straniere in Italia: non solo, dunque, i traduttori e le traduttrici, ma anche una più vasta galassia di donne e uomini dell’editoria. Editori ed editrici, direttori e direttrici di collana, consulenti editoriali, agenti letterari, scrittori e scrittrici che hanno curato o recensito l’edizione italiana di un’opera, tutti e tutte hanno avuto un ruolo nel selezionare i testi stranieri e nel presentarli al pubblico italiano, spesso suggerendo, in modo esplicito o implicito, una chiave di lettura. Ciascuno studio o “traiettoria” – il termine è preso in prestito da Pierre Bourdieu – cerca non solo di fare una ricognizione delle molteplici attività di mediazione svolte da personaggi a volte oscuri o insospettabili, ma anche e soprattutto di contestualizzarle in un sistema di relazioni estremamente dinamico, ma generalmente lasciato in ombra: quello tra i gruppi letterari di punta che decidono le nuove tendenze, le riviste letterarie e gli editori che pubblicano le collane più aperte alla letteratura straniera. L’accertamento di dati di per sé banali – se e come una certa persona abbia imparato una certa lingua straniera, da quale a quale data abbia diretto una certa collana, in che rapporti fosse con questo o quell’altro mediatore – richiede a volte un lavoro minuzioso e porta spesso a scoperte sorprendenti. La rubrica prosegue l’omonima sezione di «tradurre» e presenta in anteprima lavori che verranno poi pubblicati sul portale LTit - Letteratura tradotta in Italia (www.ltit.it).
Voce! La parola a traduttori e traduttrici
a cura di Elisa Baglioni e Ornella Tajani
«Un’autorialità derivata e non auto-originante»: con questa espressione Lawrence Venuti descrive la peculiare postura di chi traduce un testo. Traduttori e traduttrici partecipano alle vite successive di un’opera, prestando sensibilità linguistica, capacità interpretative e modalità di scrittura. Oggi, nel dibattito scientifico contemporaneo, è innegabile che la soggettività di chi traduce svolga un ruolo di primo piano all’interno del campo letterario. La rubrica Voce! nasce con l’intento di creare uno spazio in cui le voci degli «autori derivati» possano raccontare il percorso spesso impervio che porta alla versione di un’opera in altra lingua: entrare nelle pieghe del testo, attraversarne difficoltà e «zone miracolose», come scriveva Antoine Berman, può, da un lato, aiutare a comprendere meglio i meccanismi della traduzione intesa come processo, e non soltanto come prodotto finito; dall’altro, servirà a mostrare quanto la pratica traduttiva costituisca una delle forme più attente di lettura di un libro, perché ne presuppone un’interrogazione costante. Il racconto del corpo a corpo con l’altra lingua illumina, infatti, i contorni di un’attività complessa, che assume ora i colori del lavoro artigianale, ora quelli dell’atto creativo e, al contempo, richiama le intensità dell’esperienza esistenziale. Tra i segreti di bottega i principi propriamente traduttologici – perdite e compensazioni, addomesticamento e straniamento, e così via – si accompagnano ad abilità ermeneutiche, acume filologico e a una visione storica della letteratura verso e dalla quale ci si muove, creando i presupposti per cui si realizzano, con faticoso e imprevedibile stupore, le felici intuizioni. Non solo, interrogare il mestiere mette in luce il ruolo svolto da vari attori del processo editoriale che, dagli editori ai distributori, dialogano con il traduttore o la traduttrice. È tale terreno che Voce! mira a perlustrare, mostrando come la traduzione lasci, infine, tracce profonde nelle vite, poiché è esercizio di ascolto e restituzione, misura della conoscenza di sé e dell’altro. Così, attraverso interviste ad hoc, ripubblicazioni di paratesti, note di commento e materiali ibridi, questa rubrica si propone di condurre lettrici e lettori di «ri.tra» dietro le quinte della traduzione.
L’artefice aggiunto
a cura di Angela Albanese e Franco Nasi
Il titolo della rubrica riprende quello dell’antologia L’Artefice aggiunto. Riflessioni sulla traduzione in Italia, 1900-1975 pubblicata da Longo nel 2015. In quel volume i due curatori, Angela Albanese e Franco Nasi, avevano raccolto alcuni significativi scritti sulla traduzione di 42 diversi autori e autrici, (traduttori, linguisti, letterati, filosofi, giuristi, scrittori, poeti, editori italiani) che han-no delineato i movimenti dell’idea di traduzione e delle pratiche del tradurre in Italia. Questo nel tentativo di mostrare, e senza nessuna intenzione sciovinista, come in Italia sia esistita una solida tradizione della riflessione sul tradurre, spesso colpevolmente trascurata dagli studi internazionali sulla storia della teoria della traduzione. Anche nel Novecento, prima dell’affermarsi negli anni Settanta dei moderni Translation Studies, studiosi come Terracini, Folena, Mattioli, solo per citarne alcuni, avevano già indicato temi e nodi cruciali della moderna traduttologia: dalla traduzione come conflitto di lingue, alla tradizione della traduzione, alla traduzione come rapporto di poetiche. La rubrica si propone di continuare lo scandaglio delle riflessioni sul tradurre, ampliandone l’arco temporale, in particolare sondando, per ora, i secoli XVIII e XIX, che hanno visto la pubblicazione di significative elaborazioni del pensiero sul tradurre in forma di brevi saggi, interventi su riviste, note a traduzioni, dialoghi o trattati. Pensiamo ad autori come Cassoli, Cesarotti, Berchet, Leopardi, Tommaseo, degni di essere considerati in una storia della riflessione sul tradurre tanto quanto i nomi, perlopiù inglesi, francesi e tedeschi, sempre ricorrenti nelle storie internazionali.
Recensioni
a cura di Flavia Di Battista e Salvatore Spampinato
Per definire gli scopi di una rivista, le recensioni sono non solo importanti, ma essenziali: dire la propria opinione su un testo appena pubblicato può rivelarsi il miglior modo per dare risalto a un’idea o a una ricerca, e per prendere posizione in un dibattito. Del resto, la storia delle idee è piena di esempi di quanto una motivata stroncatura così come un’investitura entusiasta siano in grado di determinare la rottura di un paradigma o al contrario di rafforzare un’egemonia consolidata. La rubrica dà spazio soprattutto a recensioni di libri e report di convegni che trattano di studi di traduzione verso l’italiano, ma non esclusivamente: sarà utile non tralasciare gli studi teorici, che costituiscono l’ossatura di ogni ambito di ricerca; o ancora, assecondando la natura ibrida delle riflessioni traduzione, considerare laddove opportuno altre aree linguistiche, per trovare modelli interpretativi con cui interagire in modo proficuo. Prima di essere raccolte nei fascicoli della rivista, le recensioni saranno postate sul blog di «ri.tra». Il blog è immaginato come uno spazio di discussione in cui possano venire fuori questioni, scaturite da una lettura o da una pubblicazione, che poi verranno meditate, approfondite e sviluppate in modo più ampio in articoli successivi. Chi ci leggerà è invitato a segnalarci testi ed eventi, o a proporsi come recensore.
Dibattito e diritto di replica: la parola ai lettori
La rivista ha previsto di attivare, quando ritenuto necessario, una sezione dal titolo Repliche . Ogni discussione determinata dagli articoli pubblicati sarà condotta anche sul blog ritra.it, già attivo. Con una tempistica molto agile il blog potrà sia pubblicare contributi veri e propri sia aprire ad hoc lo spazio dei commenti, nel quale chiunque potrà intervenire in tempo reale (naturalmente con l'impegno della redazione a garantire la 'moderazione' degli stessi secondo gli standard della netiquette).
Codice etico
«ri.tra» si ispira al codice etico delle pubblicazioni Best Practice Guidelines for Journal Editors elaborato da COPE (Committee on Publication Ethics). È necessario che tutte le parti coinvolte – componenti della redazione e del comitato direttivo, autori e referee – conoscano e condividano i seguenti principi etici.
1. Doveri dei componenti del Comitato Direttivo e della Redazione
1.1. Responsabilità e Decisioni sulla pubblicazione
I contributi pubblicati da «ri.tra» sono sottoposti a un processo di peer review e di double-blind peer review e la loro pubblicazione è subordinata all’esito positivo di una valutazione anonima di due esperti scelti anche al di fuori del Comitato scientifico.
La redazione di «ri.tra Rivista di Traduzione» assegnerà a revisori competenti i saggi proposti alla rivista. Ogni manoscritto è sottoposto a due fasi di valutazione. La prima spetta alla redazione: i testi sono letti da almeno un componente del Comitato direttivo e dai responsabili della rubrica interessata. Una volta superata la prima fase della valutazione, il testo viene sottoposto a un duplice referaggio in double blind: i revisori ignorano il nome dell’autore o dell’autrice del testo sottoposto alla loro valutazione, e viceversa.
Il Comitato Direttivo è responsabile del corretto svolgimento delle procedure e approva o respinge in via definitiva i contributi. I componenti della Direzione e della Redazione non possono utilizzare, per le proprie ricerche, materiali e contenuti degli articoli proposti alla rivista senza il consenso dell’autore. I contributi dei Componenti della Direzione e della Redazione sono sottoposti allo stesso processo di peer review e double-blind peer review.
1.2. Riservatezza
I componenti del Comitato Direttivo e della Redazione non devono rivelare alcuna informazione relativa a un manoscritto sottoposto alla valutazione della rivista se non all’autore corrispondente, ai referee, referee potenziali, consulenti editoriali, e all’editore, secondo i casi. La direzione conserva tutti i risultati dei processi di referaggio dei contributi proposti alla rivista.
1.3. Correttezza
La direzione e la redazione valutano i contributi proposti in base al loro contenuto, senza discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico degli autori.
1.4. Qualità
La direzione e la redazione garantiscono la qualità scientifica dei lavori pubblicati e il rispetto della libertà di espressione e del diritto di replica.
2. Doveri dei referee
2.1. Contributo alla decisione editoriale
La procedura della peer-review aiuta i Curatori e la Direzione nel processo di valutazione degli articoli proposti alla rivista e può aiutare l’autore a migliorare il proprio contributo. I revisori sono scelti dalla Redazione.
2.2. Rispetto dei tempi
Il referee che sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto a darne tempestiva comunicazione ai Direttori.
2.3. Riservatezza e oggettività
Ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato. Pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone senza esplicita autorizzazione dei Direttori. I revisori sono tenuti a essere del tutto obiettivi nei loro giudizi, ad argomentare in maniera chiara la loro valutazione, a segnalare eventuali casi di mancata indicazione delle fonti, di affermazioni non veritiere, di plagio o di violazione del diritto d’autore compilando una scheda fornita loro dalla Redazione. I revisori sono tenuti a fornire agli autori indicazioni utili al miglioramento del loro lavoro. Ogni giudizio personale sull’autore è inopportuno.
2.4. Conflitto di interessi e divulgazione
I revisori sono tenuti a rifiutare la valutazione di articoli rispetto ai quali abbiano un conflitto di interessi di qualsiasi tipo. I revisori sono tenuti a non utilizzare per finalità personali le informazioni riservate o confidenziali ottenute durante il processo di peer-review.
3. Doveri degli autori
3.1. Originalità, plagio e indicazione delle fonti
Gli autori sono tenuti a dichiarare di avere redatto un lavoro originale in ogni sua parte e di avere citato tutti i testi utilizzati. L’autore deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell’articolo. Non è tollerata alcuna forma di plagio.
3.2. Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti
Gli autori propongono articoli inediti e non sottoposti a processo di valutazione presso un’altra rivista. Sottoporre contemporaneamente lo stesso testo a più di una rivista costituisce un comportamento eticamente non corretto e inaccettabile. «ri.tra» si riserva la possibilità di ripubblicare testi già editi altrove, indicandone con chiarezza la provenienza. Gli articoli pubblicati su «ri.tra» possono essere ripubblicati in volume, su altri siti e blog, previa autorizzazione del Comitato Direttivo, purché rispettino la Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate - Internazionale (Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International) CC BY-NC-ND 4.0 DEED.
3.3 Sanzioni
Nel caso in cui un/una Componente della Direzione o della Redazione, un Revisore o un Autore/un'Autrice non rispettasse le norme previste dal Codice etico, le/gli sarebbe preclusa la possibilità di ulteriori collaborazioni con «Ri.Tra». Inoltre se si accertasse che un articolo già pubblicato non rispetta le suddette norme, esso verrà rimosso dal sito di «Ri. Tra» e sarà sostituito da una nota informativa del fatto che il testo è stato rimosso in quanto non rispettoso del Codice etico della rivista.